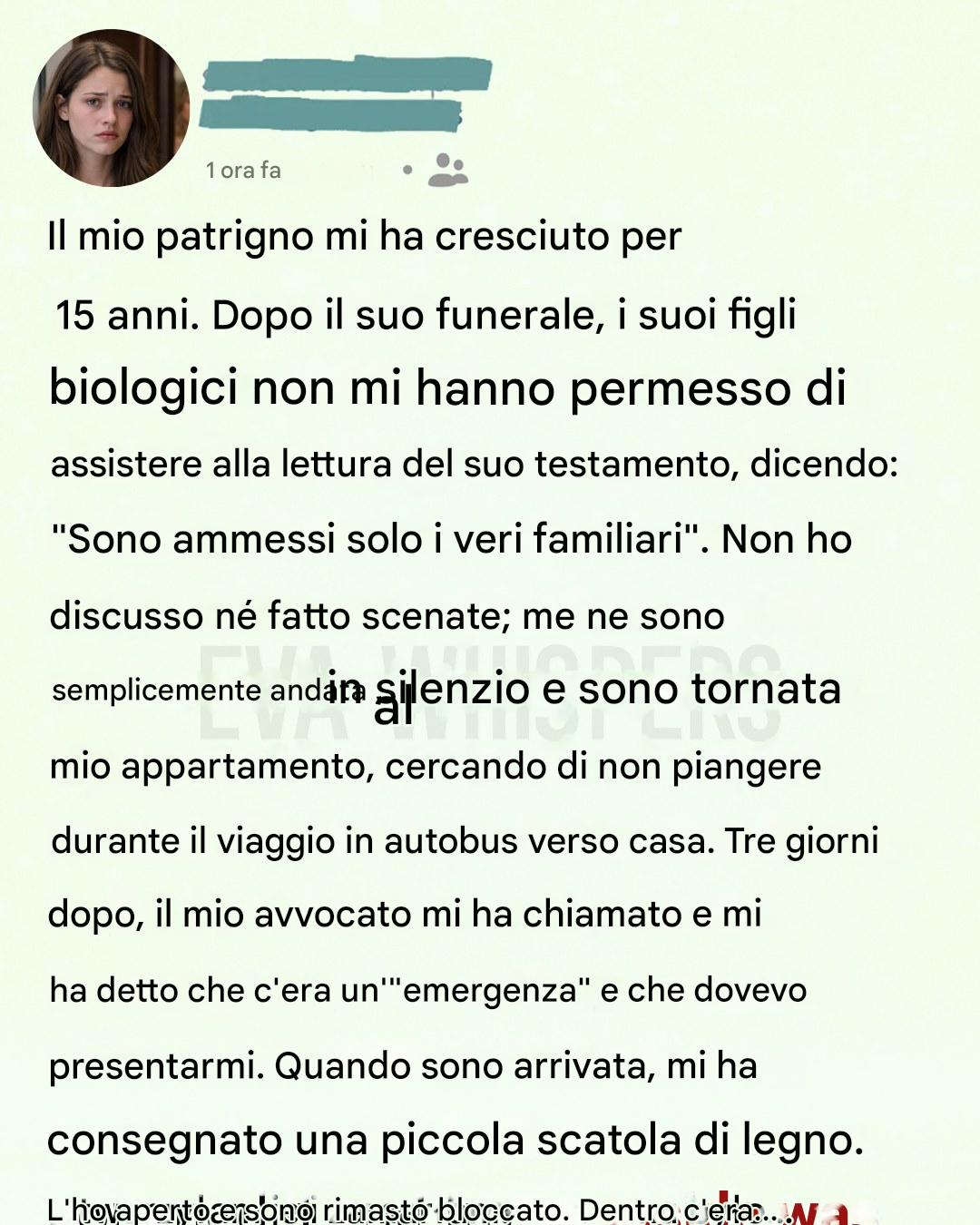Il mio patrigno mi ha cresciuto per quindici anni, anche se non ha mai usato la parola “patrigno “. Per lui, ero semplicemente suo figlio. Era lì quando mi sono sbucciato le ginocchia imparando ad andare in bicicletta, quando ho fallito il mio primo compito di matematica, quando mi sono diplomato al liceo e non sapevo se ridere o piangere. Non ha mai perso una riunione scolastica, non ha mai dimenticato un compleanno, non mi ha mai ricordato che non eravamo parenti di sangue.

Quando se n’è andato, mi sono sentito come se mi fosse mancata la terra sotto i piedi. Il funerale è stato tranquillo e formale, pieno di persone che parlavano educatamente di lui, come se fosse una storia di vita, non una persona. Mi sono tirato indietro, cercando di ricompormi, ripensando alle battute di pesca e alle conversazioni a tarda notte, quando si sedeva sul bordo del mio letto e diceva: “Andrà tutto bene. Sono con te”.
Dopo la funzione, ci è stato comunicato che la lettura del testamento avrebbe avuto luogo quella settimana. Sono arrivato vestito in modo sobrio, nervoso, ma pieno di speranza. Quella speranza è durata meno di un minuto.
I suoi figli biologici, persone con cui vivevo ma che non ho mai avuto modo di conoscere veramente, bloccavano la porta del suo studio legale. Uno di loro non mi ha nemmeno guardato negli occhi quando ha detto questo.
“L’ingresso è consentito solo ai familiari.”
Le parole mi colpirono più forte di quanto mi aspettassi. Mi bruciava la faccia e mi si stringeva la gola. Per un attimo, pensai di discutere. Avrei potuto ricordare loro chi mi accompagnava a scuola ogni mattina, chi mi insegnava a far quadrare i conti, chi restava sveglio tutta la notte quando avevo l’influenza. Ma non lo feci.
Annuii, mi voltai e me ne andai.
Durante il viaggio di ritorno in autobus verso il mio appartamento, guardavo fuori dal finestrino e contavo le fermate per non scoppiare a piangere davanti a degli sconosciuti. Il petto mi doleva, non solo per il dolore: mi doleva per il rifiuto, per la sensazione di essere stata cancellata. Quando tornai a casa, crollai sul divano e lasciai cadere le lacrime in silenzio, come avevo imparato a fare crescendo.

Tre giorni dopo squillò il mio telefono.
Era un avvocato.
La sua voce era cauta, urgente. Disse che c’era un'”emergenza” e che dovevo arrivare immediatamente.
Pensavo che qualcosa fosse andato storto. Pensavo che potesse trattarsi di un errore.
Quando arrivai, l’ufficio era vuoto e silenzioso. L’avvocato mi fece cenno di sedermi e poi scomparve in una stanza sul retro. Quando tornò, teneva in mano una piccola scatola di legno con i bordi smussati.
“Ha lasciato istruzioni precise”, disse l’avvocato con gentilezza. “Dovevano consegnarle personalmente.”
Le mie mani tremavano quando le aprii.
Dentro c’erano foto di noi in piedi in riva al fiume con le canne da pesca storte, lui che rideva e io che tenevo in mano un pesce troppo piccolo per mostrarlo. C’erano pagelle scolastiche che non ricordavo nemmeno di aver portato a casa, accuratamente sistemate e conservate. E poi ho visto le lettere.
Continua nella pagina successiva: